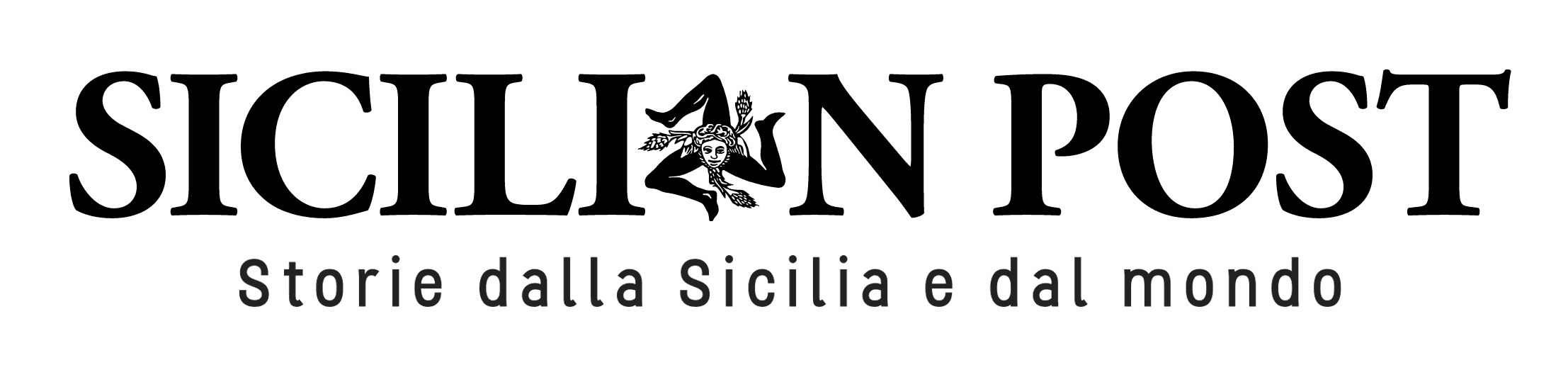Quel Primo Maggio di sangue: il mistero senza fine della Strage di Portella della Ginestra
L’Italia e la Sicilia sono appena uscite dal dolore della Seconda guerra Mondiale. Ma nel giorno della Festa dei lavoratori del 1947, a poca distanza da Piana degli Albanesi, un eccidio, compiuto ai danni dei manifestanti che stavano celebrando la vittoria della Sinistra alle elezioni regionali, sconvolge l’opinione pubblica. Come responsabili vengono immediatamente indicati Salvatore Giuliano e la sua banda. Ma gli intrighi e le ombre di questa vicenda appaiono subito numerosi. Tanto che ancora oggi, a 78 anni dai fatti, molto sfugge ancora. Mentre i lavoratori, allora vessati, continuano a lottare per la loro sicurezza e per il loro compenso
Si erano riuniti in quasi duemila per manifestare e godersi una festa che per più di vent’anni gli era stata negata dal regime fascista. Ma nel verde altopiano di Portella della Ginestra, a pochi chilometri da Piana degli Albanesi, quel Primo Maggio del 1947 li aspettavano i fucili. Undici morti sul colpo, di cui tre bambini, e una trentina di feriti (tre moriranno in seguito per le ferite riportate). La loro colpa? Manifestare per una Italia e una Sicilia più giuste e democratiche, libere dalla miseria e dalla mafia dei latifondi, in cui i diritti dei lavoratori potessero finalmente diventare realtà. A colpire, secondo la versione ufficiale, la banda del bandito Salvatore Giuliano. I nomi dei mandanti? Da sempre avvolti nel mistero.
IL CONTESTO. Dopo vent’anni di dittatura e due di guerra civile, in Italia si cominciava finalmente a respirare l’aria della democrazia. La Repubblica si era affermata nel referendum meno di un anno prima e i lavori dell’Assemblea Costituente avanzavano. Nella Sicilia che solo un anno prima aveva votato in stragrande maggioranza per la monarchia, però, quella primavera del 1947 fu un momento cruciale di lotta politica e sociale. Il 20 aprile, il Blocco del Popolo – l’alleanza tra socialisti e comunisti – aveva trionfato alle elezioni regionali a scapito della Democrazia Cristiana.
Una vittoria che aveva conferito nuova forza al movimento contadino, che si batteva per uscire dalla miseria chiedendo terra, lavoro e diritti. Ma che, nel contesto della crescente divisione in blocchi della Guerra Fredda, aveva anche spaventato molti: la mafia, i latifondisti, i monarchici e forse anche gli alleati americani, preoccupati per l’avanzata della sinistra. Quel Primo Maggio fu occasione, per circa duemila persone, lavoratori, contadini, le loro famiglie e il sindacato, di festeggiare l’importante vittoria elettorale e manifestare contro il latifondismo (approfittando per trovare un pasto gratuito). Lo fecero in un luogo simbolico: tra i comuni di Piana degli Albanesi, San Giuseppe Jato e San Cipirello, dove Nicola Barbato, esponente di spicco del socialismo siciliano di inizio ‘900, era solito tenere i suoi discorsi.
«Cercavamo un diritto che ci apparteneva – dirà anni dopo Serafino Pecca, sopravvissuto alla strage – non era possibile che qui quattro o cinque persone che avevano ettari di terreno dettassero legge… Era gente che moriva di fame». La strage che si compì il 1º maggio 1947 fu, come scrive Emanuele Macaluso – dirigente comunista, sindacalista e deputato siciliano – nel suo saggio “Portella della Ginestra. Strage di Stato?” «un feroce atto intimidatorio per tutto il movimento contadino di quegli anni e per l’avanzata delle sinistre nelle elezioni del 1947».

GLI ASSASSINI E IL MISTERO SUI MANDANTI. Alle 10.30 del mattino, a Portella della Ginestra, la gioia della festa fu squarciata da circa 800 colpi di mitragliatrice che durarono 15 minuti. Tra il panico e i volantini rossi che svolazzavano nell’aria, rimasero a terra undici cadaveri, tra cui tre bambini, e decine di feriti. La versione ufficiale arrivò in fretta: a sparare era stata la banda di Salvatore Giuliano, il celebre bandito anticomunista di Montelepre, già noto alle cronache siciliane. Ma da subito iniziarono a circolare sospetti riguardanti i veri responsabili dell’attacco: si parlò di una lettera arrivata a Giuliano la sera prima della strage e poi bruciata, di un piano organizzato dall’alto, di mandanti politici.
Negli anni successivi, durante il processo di Viterbo, Gaspare Pisciotta – braccio destro di Giuliano – accusò apertamente dirigenti politici monarchici e democristiani, sostenendo che avevano affidato alla banda l’incarico di colpire la manifestazione del Primo Maggio per frenare l’avanzata della sinistra in Sicilia. Tuttavia, Pisciotta, che tra gli altri accusò l’allora ministro dell’interno Mario Scelba (DC), non venne mai ritenuto attendibile poiché fornì nove diverse versioni durante il processo. Nel 1952, la sentenza stabilì che l’unica responsabile della strage era la banda Giuliano, ma molte delle piste sollevate rimasero nell’ombra. Due anni dopo, nel 1954, Pisciotta morì avvelenato con stricnina nel carcere dell’Ucciardone. A distanza di decenni, nuove ipotesi sono emerse. Secondo alcuni storici, la strage potrebbe essere il primo tassello della “strategia della tensione”. L’allora Ministro dell’Interno Scelba parlò di un “fatto isolato”, ma la memoria collettiva non gli ha mai creduto davvero.
Come scrive Pino Corrias in Nostra incantevole Italia, Portella fu più di una strage: «La loro fine è l’inizio della nostra storia repubblicana, la parte più nera, che ha radici nell’eterna Sicilia della miseria e dei misteri, del potere mafioso che dopo la fine della guerra regna come prima sull’isola e arriva fino a Roma, complice il nuovo ordine angloamericano, ossessionato dall’anticomunismo, e quello vecchio della Chiesa che tiene genuflesso nella superstizione un intero popolo, meglio analfabeta che bolscevico». Anche Emanuele Macaluso, nel suo saggio Portella della Ginestra. Strage di Stato?, afferma con decisione: «La strage di Portella della Ginestra è la prima strage di Stato».

LA STRAGE NELLA MEMORIA POPOLARE. La memoria della strage di Portella della Ginestra è tenuta costantemente viva nella cultura popolare siciliana e italiana, grazie a canzoni, film, dipinti e manifestazioni. Nella musica, la memoria della strage è stata tramandata attraverso le parole della poesia Purtedda da Ginestra di Ignazio Buttitta, interpretata da artisti come Rosa Balistreri e Tano Avanzato. Più recentemente, il cantautore Alessandro D’Andrea Calandra, con la canzone L’ùrtimu maju, ha raccontato il dolore e la rabbia di quel Primo Maggio di 78 anni fa.
Il cinema, con opere come Segreti di Stato di Paolo Benvenuti, denuncia i misteri legati alla strage; e l’arte visiva, con i dipinti dei palermitani Renato Guttuso e Gaetano Porcasi mantengono viva la memoria di quel giorno.
Ogni anno nel luogo della strage, dove l’artista Ettore de Conciliis ha progettato il Memoriale di Portella della Ginestra, si rinnova la commemorazione ufficiale con la lettura dei nomi delle vittime. Anche stamattina 1° maggio 2025, a Portella della Ginestra, si è tenuta la manifestazione dal titolo “Partigiani del lavoro”, promossa da CGIL Sicilia, CGIL Palermo e ANPI, per ricordare le vittime e ribadire l’attualità della lotta per il lavoro, la dignità e la giustizia sociale.
(In copertina: un fotogramma tratto dal film di Francesco Rosi “Salvatore Giuliano”, 1960)