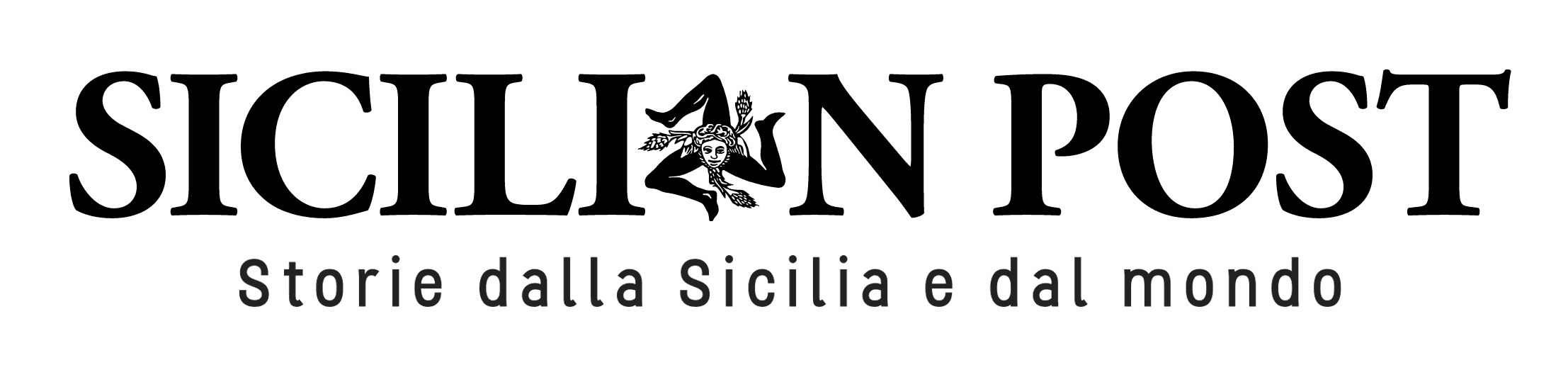Il fardello e la dolcezza degli addii: Quasimodo e il saluto alla madre scomparsa
Tra le liriche di “Giorno dopo giorno”, quella di commiato per la donna che lo ha cresciuto e sostenuto in ogni aspetto della sua vita è forse la più intima e sentita. Ma da questa dimensione strettamente personale emerge anche qualcosa di universale: la nostra incapacità di rassegnarci al distacco. I nostri disperati tentativi di ignorare, rinviare, accantonare quei momenti. Il mistero per cui un addio sa essere allo stesso tempo straziante e carico di bellezza
Fu lapidario, quella volta, Rainer Maria Rilke. Fulmineo e fulgente, come i sussurri trattenuti da un cuore lacerato. Come il finale di un racconto che si scioglie, scompare, si dilegua silenzioso alle spalle dei personaggi che lo hanno scritto. Disse questo, struggendosi per chissà quale distacco, per chissà quali occhi: «Noi viviamo per dire sempre addio». Vi siamo stati quasi destinati, incatenati come novelli Prometei. Il nostro esistere coincide con il lasciare andare, con la separazione, con le intercapedini dell’anima che restano sospese, frammentate, disperse. È parte di noi, l’addio, ma lo rifiutiamo. Non sappiamo – non vogliamo – venirci a patti. Lo malediciamo, lo posticipiamo, lo ignoriamo come se volgere lo sguardo altrove potesse esorcizzarlo. Fuggiamo le sue formule, i suoi riti insostenibili, le parole sempre, inesorabilmente inadeguate ad esprimerne l’intensità. Culliamo sino all’ultimo la speranza di aggirarlo, di planare al di là dell’assenza. E lo facciamo in maniera controintuitiva, mentre percepiamo i nostri sensi essere sconvolti dal suo avvicinarsi a grandi passi, mentre i fantasmi del passato prendono per mano quelli presenti, mentre la lontananza impone progressivamente la sua legge. Si voltano le spalle all’addio, forse, proprio come si fa con la morte. Perché andarsene, svanire alla vista di qualcuno, abbandonarlo su un piano dell’esistenza ormai inconciliabile con il nostro è un po’ morire. Arrendersi all’evidenza. Deporre le armi di una prolungata resistenza. E torna alla mente l’eco di quei versi antichi, il cupo candore poetico di Salvatore Quasimodo. Quella missiva lirica, quel commiato sofferto e intrappolato, quel richiamo disperato al cospetto di una distanza incolmabile. Quando in Giorno dopo giorno si lasciò andare ad uno dei canti più intimi della propria produzione. Quando anche lui, poeta consumato, interprete di quell’arte che anela a sfiorare le vette dell’eternità, dovette constatare la sua umanità. La realtà che neanche il verso può coprire il silenzio di un addio.
Lo sorprese lì, il dolore. Dove sapeva di trovarlo scoperto, inerme. Nell’impossibilità di ricongiungersi a chi gli aveva dato la vita. Nei respiri stanchi di vagare tra sguardi sconosciuti. Lettera alla madre è più che un saluto: è un testamento doppio, una disperata utopia di ricongiungimento, il sigillo su un legame che può solo guardarsi indietro per non smarrirsi del tutto. Si apre una finestra, tra i versi e le lacrime: una finestra di rimpianto, per quell’interminabile girotondo che li ha divisi. Ma anche di gratitudine: per la pazienza, la benevolenza, l’amore incondizionato per le scelte ardite, complicate, a volte persino testarde di un figlio. C’è la dolcezza di ciò che è stato; la matura rassegnazione per ciò che sarà. L’impotenza e il fascino del fare poesia dinanzi all’irreparabile:
«Mater dolcissima, ora scendono le nebbie,
Salvatore Quasimodo, “Lettera alla madre”
il Naviglio urta confusamente sulle dighe,
gli alberi si gonfiano d’acqua, bruciano di neve;
non sono triste nel Nord: non sono
in pace con me, ma non aspetto
perdono da nessuno, molti mi devono lacrime
da uomo a uomo. So che non stai bene, che vivi
come tutte le madri dei poeti, povera
e giusta nella misura d’amore
per i figli lontani. Oggi sono io
che ti scrivo.» – Finalmente, dirai, due parole
di quel ragazzo che fuggì di notte con un mantello corto
e alcuni versi in tasca. Povero, così pronto di cuore
lo uccideranno un giorno in qualche luogo. –
«Certo, ricordo, fu da quel grigio scalo
di treni lenti che portavano mandorle e arance,
alla foce dell’Imera, il fiume pieno di gazze,
di sale, d’eucalyptus»
È lo sconcerto, il grande compagno di ogni addio. L’evidenza che, a dispetto dei nostri infantili bisticci con la sua forza, della nostra ostinazione nell’ignorarlo fino all’ultimo istante, esistono momenti che gli appartengono. Cocci di inganno da raccogliere. Illusioni da accantonare, anche solo per lo spazio di uno pianto. Per lo spazio di una giovinezza che si allontana. Veloce, sì, anche quella, come le sillabe di un addio.
«Ma ora ti ringrazio,
Salvatore Quasimodo, “Lettera alla madre”
questo voglio, dell’ironia che hai messo
sul mio labbro, mite come la tua.
Quel sorriso m’ha salvato da pianti e da dolori.
E non importa se ora ho qualche lacrima per te,
per tutti quelli che come te aspettano,
e non sanno che cosa. Ah, gentile morte,
non toccare l’orologio in cucina che batte sopra il muro
tutta la mia infanzia è passata sullo smalto
del suo quadrante, su quei fiori dipinti:
non toccare le mani, il cuore dei vecchi.
Ma forse qualcuno risponde? O morte di pietà,
morte di pudore. Addio, cara, addio, mia dolcissima mater»
Cosa resta, allora, dopo un lungo saluto? Resta tutto. Tutto il bene che lo ha generato. Tutta l’amarezza delle cose che non si possono cambiare. Restano sguardi, sorrisi, singhiozzi, rimpianti. Resta tutto. Come un peso da sopportare. Come un refolo di brezza che ti solleva e ti conduce altrove.
(Immagine in copertina realizzata con Image Bing Creator)