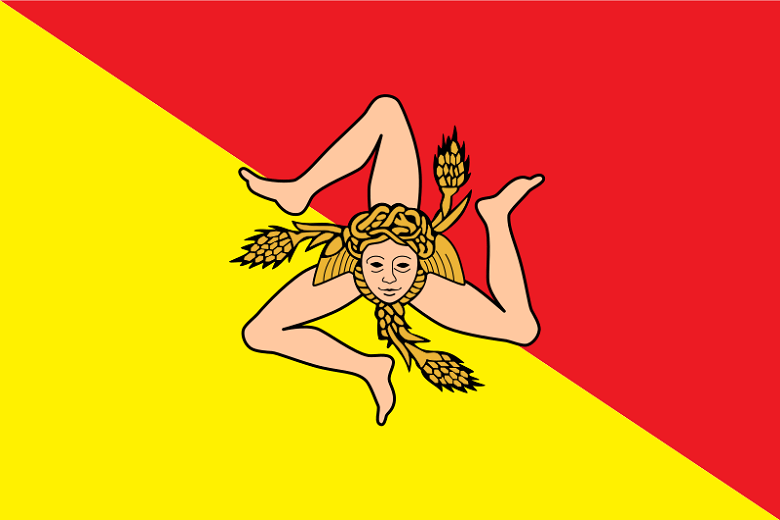Carlo Levi, il non siciliano che più ha catturato il vero spirito dell’isola
Lo scrittore e giornalista torinese, tra i forestieri approdati nella nostra terra, fu uno dei pochissimi ad innamorarsi non solo delle sue bellezze, ma anche delle sue miserie e del suo senso di riscossa. Come quello dei contadini di Bronte, condannati dai crimini di Bixio ed emblema di una attesa palpitante verso il futuro