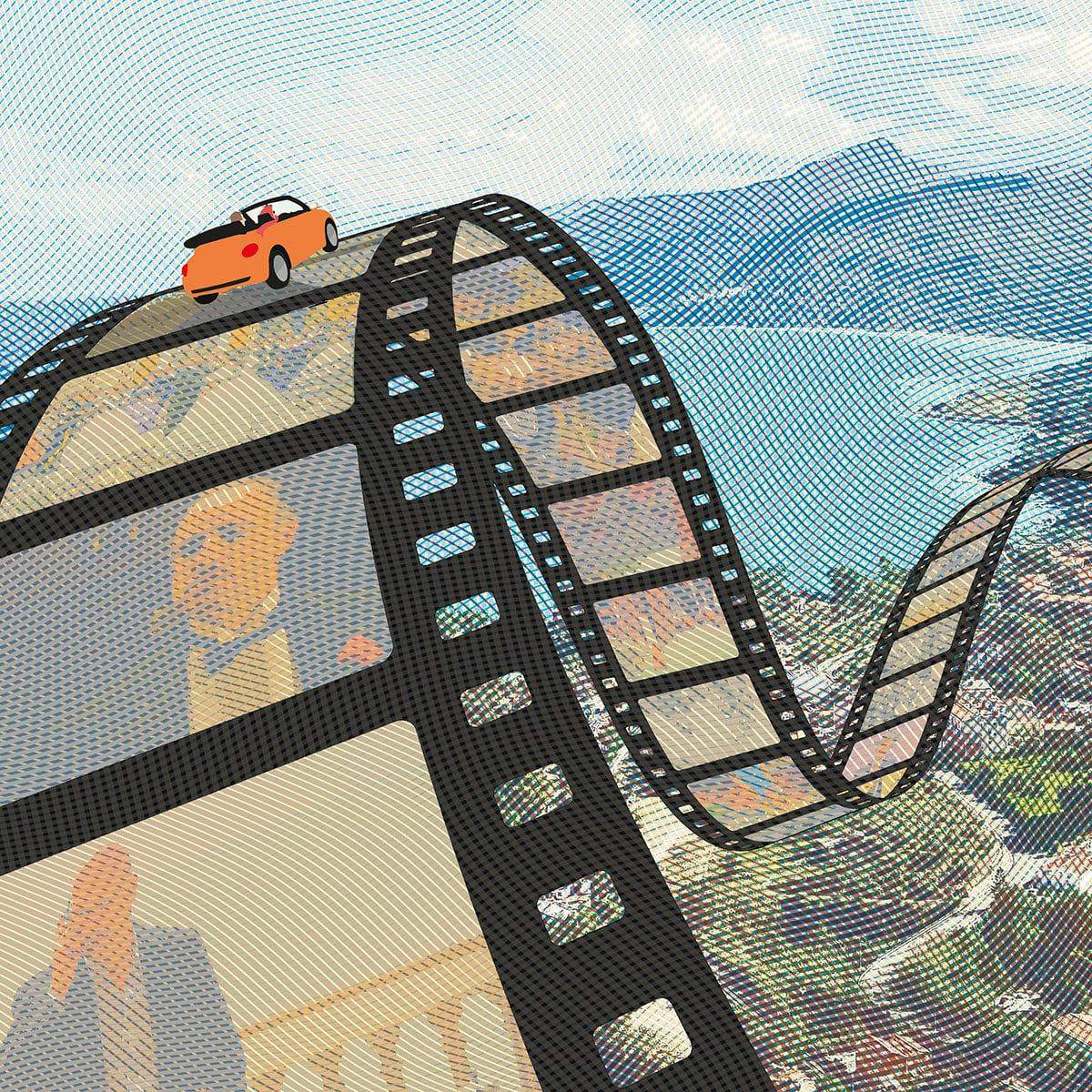Gabriele Lavia: «Un attore non deve recitare con uno spartito in mano, ma fare jazz»
In scena fino al 2 aprile al Teatro Stabile di Catania con “Il sogno di un uomo ridicolo” di Fëdor Dostoevskij, l’attore milanese ci ha raccontato il suo legame con i grandi autori del teatro, l’amicizia con Strehler e il prossimo progetto che lo vedrà impegnato in un testo poco noto di Carlo Goldoni