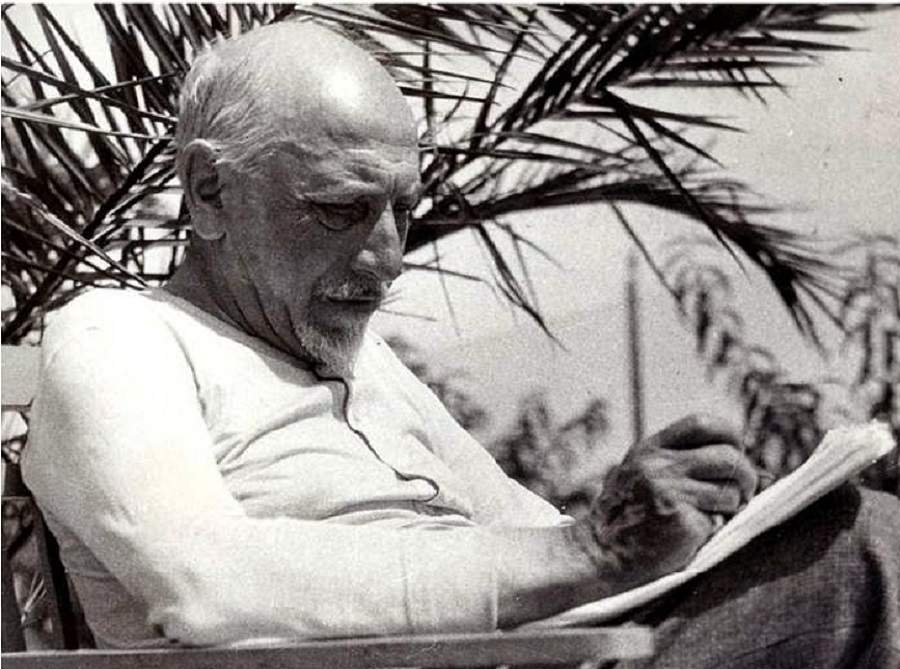Da Jeli al marchese di Roccaverdina: quando follia fa rima con impotenza
Impersonali, oggettive, fredde. Sono questi gli attributi che spesso vengono affibbiati alle narrazioni veriste. Le quali, tuttavia, hanno invece indagato con grande maestria le pieghe dell’animo umano. Regalandoci drammi di struggente importanza