Giuseppe Bonaviri: la magia del tempo in un mondo di solitudini
Nativo di Mineo, presso cui fin da giovane rimase affascinato dal mito della pietra della poesia, lo scrittore siciliano ha saputo tenere insieme nelle sue opere il racconto delle piccole consuetudini e i grandi temi metafisici. La sua visione cosmica dell’uomo, e dell’isola, ci spingono ancora a sondare l’ignoto, dentro e fuori di noi. Alla ricerca di un infinito che ha il volto della libertà







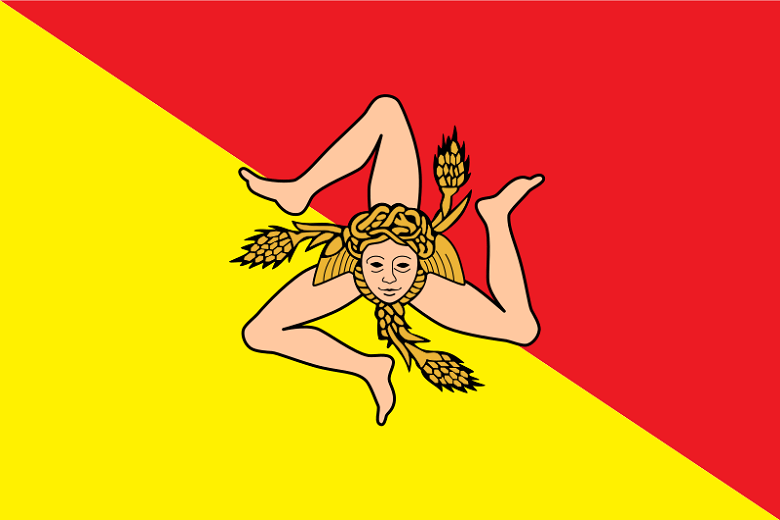
Leggo con profonda gratitudine questo articolo che mi restituisce un ricordo di più di vent’anni fa . Un’ amica preparava la sua tesi su Bonaviri e io ebbi così la fortuna di scoprirlo.
Oggi la meditata analisi dell’ Autore dell’ articolo me lo fa riscoprire e rinnova il piacere della lettura di pagine così singolarmente custodi della nostra sicilitudine.