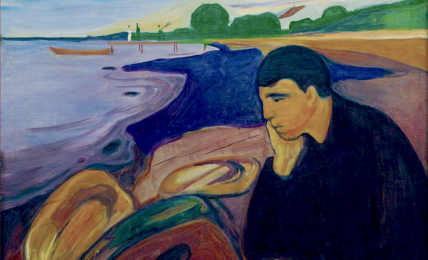“La stranezza” dimostra che la complessità può essere sinonimo di successo
Il film di Roberto Andò, con Toni Servillo e Ficarra e Picone, dopo gli ottimi risultati dell’esordio continua imperterrito ad apparire nelle programmazioni dei cinema, anche a fronte di una trama spesso intricata. Un’inversione di tendenza nel periodo in cui le sale rimangono vuote e in cui la complessità è mal digerita. Che la riuscita messa in scena di uno spaccato della poetica di Pirandello ne abbia, invece, rivelato l’importanza e la bellezza?