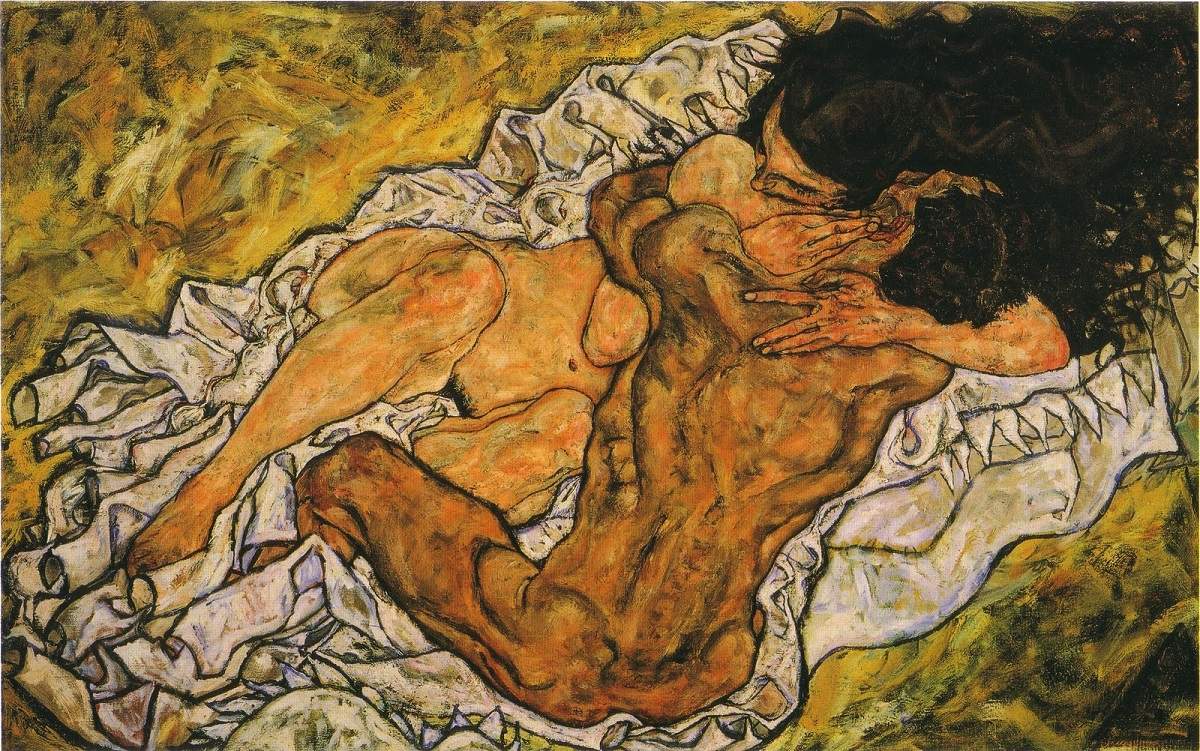Morire da fantasma nel centro di una metropoli: Verga e la condanna di “L’ultima giornata”
Nel 1883, lo scrittore siciliano, all’interno di “Per le vie”, incluse una novella oggi poco conosciuta, la quale, tuttavia, ha un sapore quasi profetico. È la storia di un clochard che si accascia al suolo alla stazione ferroviaria di Milano. La storia di tanti senza nome e senza voce che continuano, oggi, a scomparire nell’anonimato. La storia di come neanche la morte, nel caos di una vita spesa a correre e a guardare solo sé stessi, faccia più scandalo o pietà. La storia di come abbiamo iniziato ad essere l’uno lo straniero dell’altro