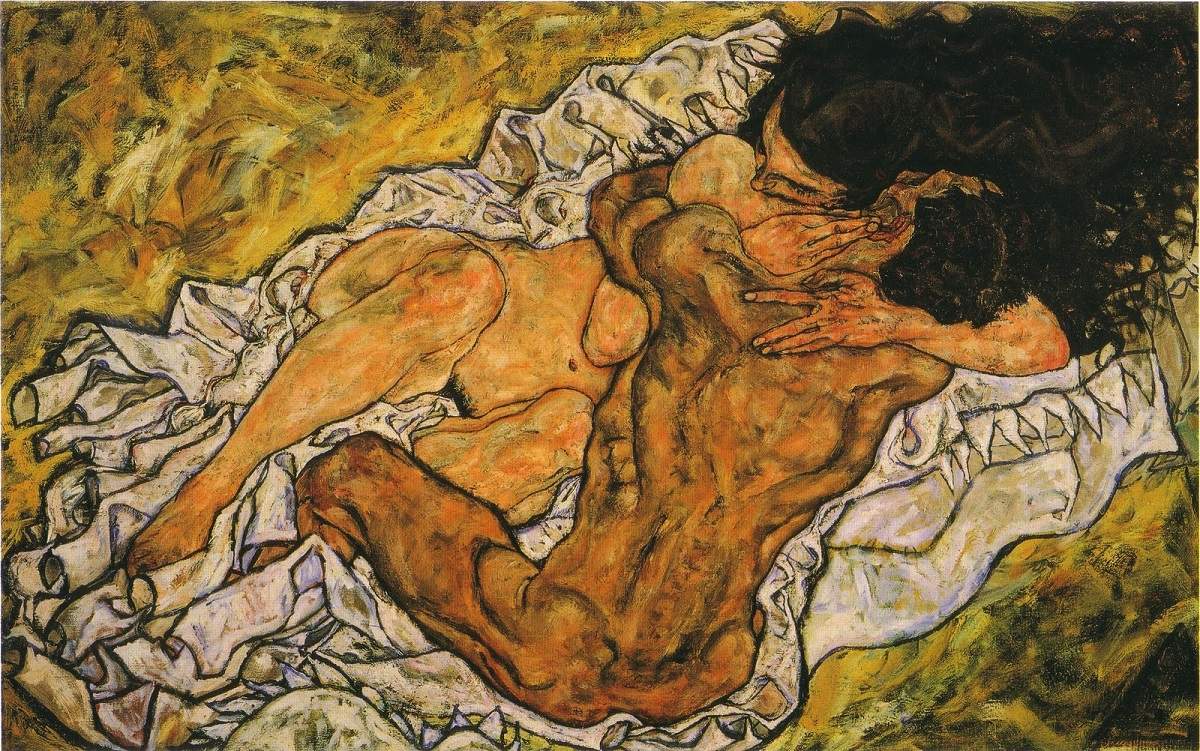Ucciso perché straniero: nella poesia di Buttitta l’incredibile storia vera di un operaio siciliano
Si intitola “U Razzismu” la lirica che il poeta isolano dedicò a Nunzio Licari, padre di cinque figli emigrato da Catenanuova (EN) verso la Germania e qui aggredito a morte da un giovane tedesco che confessò alla polizia di averlo fatto perché non sopportava la presenza di stranieri nella propria patria. Un episodio a dir poco drammatico, a cui il poeta restituisce la dignità della memoria e che mai come oggi, ripercorrendo le ombre dell’emigrazione dei nostri conterranei, ci invita a riflettere sul perché anche il nostro presente sia così insozzato di odio