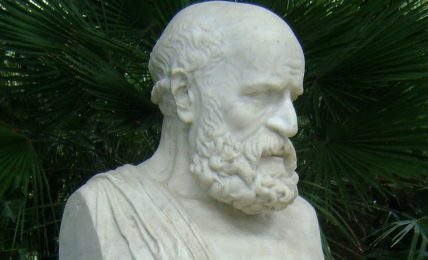Da Ibn Hamdis a Quasimodo: da secoli la Sicilia ispira il canto della nostalgia
«Se sono stato cacciato da un Paradiso come posso darne notizia?». La forza della poesia oltrepassa quella del tempo: attraverso essa generazioni di poeti siciliani hanno inseguito la felicità perduta e una parte di loro stessi rimasta nel passato